Sen-เส้น, è voce che, all’interno della terminologia tecnica, propria di quell’orientamento epistemologico, su cui si fonda il pensiero della medicina orientale e conseguentemente una delle sue branche, ovvero il Massaggio Tradizionale Thailandese o นวดโบราณ-Nuad Börarn in lingua thai, designa quelle linee o quei percorsi, equiparabili ai meridiani cinesi, che costituiscono delle aree pseudo-anatomiche in cui affiorano le energie sottili[1] entro la compagine somatica.
 Dal punto di vista semantico la parola copre una considerevole varietà di significati, sinonimi ed eteronimi, come ad esempio: linea, striscia, nastro, vaso, filamento, filo, fune, corda, eccetera. Da un approfondimento etimologico circa la genesi del fonema sen-เส้น, traspare manifesta l’assonanza del termine in questione con la parola cinese: xiàn (pron. sien) 线, rettificata in tempi recenti dal “Grande Timoniere”, 毛泽东 Máo Zédōng, con l’imposizione dei caratteri semplificati, la cui variante classico-allografa, è 線, a sua volta omografa quantunque omofona alla pronuncia “on”[2] di “sen” del giapponese[3]. Dal punto di vista semantico la parola copre una considerevole varietà di significati, sinonimi ed eteronimi, come ad esempio: linea, striscia, nastro, vaso, filamento, filo, fune, corda, eccetera. Da un approfondimento etimologico circa la genesi del fonema sen-เส้น, traspare manifesta l’assonanza del termine in questione con la parola cinese: xiàn (pron. sien) 线, rettificata in tempi recenti dal “Grande Timoniere”, 毛泽东 Máo Zédōng, con l’imposizione dei caratteri semplificati, la cui variante classico-allografa, è 線, a sua volta omografa quantunque omofona alla pronuncia “on”[2] di “sen” del giapponese[3].
Quanto detto fin qui, risulterebbe già essere un dato degno d’attenzione, essendo, ipso facto, un prodromo della presenza di loanwordcinesi nella terminologia del Massaggio Thailandese, risalenti verosimilmente, a quell’epoca leggendaria in cui esso non era stato completamente standardizzato. A dispetto di ciò e soprattutto del modus operandi dello stesso, emerge, tuttavia, quella che sembra essere un’ulteriore aporia: l’inconfutabilità circa la genesi indiana del sistema speculativo-epistemologico su cui si fonda il massaggio in questione.
Gli appellativi stessi con cui sono designati i tre più importanti sen sono degli esempi la cui apoditticità risuona anche all’orecchio meno avvezzo: Sumana, Ittha, Pingkhala, infatti, in virtù dell’omofonia diretta con le rispettive Sušumnā nādī, Idā nādī e Pingalā nādī, piuttosto che all’omologa tradizione cinese dei meridiani, rimandano inequivocabilmente allo Yoga medico e tantrico, della specie hatha elaya, appartenenti quasi certamente all’ambito del Śaivasiddhanta, ed alla Śiva Samhitā, descritti nelle opere di P.Filippani Ronconi,M.Eliade e A.Avalon[4]. Nādī, il cui significato letterale è quello di fiume, è, infatti, la parola che in sanscrito indica i succitati percorsi in cui circola il prāna, l’energia sottile. Non essendo legati necessariamente ad una fisiologia meccanicistica, li abbiamo definiti aree pseudo-anatomiche di risonanza energetica.
La speculazione indiana dello Yoga concepisce detto prāna secondo due polarità dinamiche, quella “solare”, rossastra ed ignea oPingalā e quella “lunare”, pallida e tellurica: Idā, oltre che secondo altre otto forme differenti, che analizzeremo più avanti. Le due polarità, la cui alternanza permette il sorgere dei fenomeni vitali, si avviluppano attorno alla colonna vertebrale, che è la sede diSušumnā, la terza nādī ubicata all’interno dell’asse cerebro-spinale, mitologicamente assimilata all’Axis Mundi, al monte Meru oSumeru della tradizione induista, sede delle trentatré divinità vediche, nel cui nome M.Eliade ravvisa un innesto di complessi mitologici d’origine mesopotamica[5].
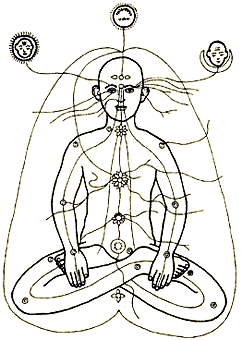 Tali nādī, dette anche sirā, sebbene quest’ultimo termine possieda un’accezione maggiormente iletica, altro non sarebbero se non dei “dotti metasomatici”, che veicolano il flusso dell’energia cosmica e divina dall’interno degli organi soprasensibili di quella fisiologia mistica, detti in sanscrito, cakra, “cerchi” e kamala “fiori di loto”, verso i marmam che sono i “punti sensibili”, quelli che lo shiatsuchiama tsubo e Tali nādī, dette anche sirā, sebbene quest’ultimo termine possieda un’accezione maggiormente iletica, altro non sarebbero se non dei “dotti metasomatici”, che veicolano il flusso dell’energia cosmica e divina dall’interno degli organi soprasensibili di quella fisiologia mistica, detti in sanscrito, cakra, “cerchi” e kamala “fiori di loto”, verso i marmam che sono i “punti sensibili”, quelli che lo shiatsuchiama tsubo e
Questi marmam, in ogni caso, appartengono ancora a quella che potremmo definire una fisiologia somatica, in senso stretto o esteriore (…)”[8]. In merito a ciò ci appare sintomatico il fatto che lo studioso, pur menzionando il tradizionale kuatsu, non abbia fatto alcun riferimento - non sappiamo quanto intenzionalmente - allo shiatsu, questa neotecnica nippo-americana, d’ampia diffusione da qualche decennio a questa parte, una singolare miscellanea dall’origine alquanto spuria e rocambolesca. M.Eliade e A.Avalon, citando il summenzionato testo della Śiva Samhitā, descrivono le rimanenti nādī, specificandone l’esistenza di un numero considerevole, il che - per inciso - spiega altresì l’apparente contraddizione circa la diversificazione dei loro percorsi all’interno delle varie tradizioni.
In alcuni testi si parla di 300.000 nādī, indi di 200.000, di 80.000, soprattutto di 72.000, fra cui 72 aventi una particolare importanza, e ancora fra queste A.Avalon ne enumera 14, mentre M.Eliade ne sintetizza 10, che, a nostro avviso sono assimilabili ai dieci sen. Esse sono: Idā, Pingalā, Sušumnā, Gānadhārī, Hastijihvā, Pūsā, Yasasvinī, Ālambusā, Kūhūc eCamkhinī, le quali, benché non trovino una precisa assonanza con i sen thailandesi, Ittha, Pingkhala, Sumana, Sahatsarangsi,Thawari, Ulangka, Lawusang, Kalathari, Kitchanna, Nanthakrawat, riscontrano altresì una precisa corrispondenza nell’ubicazione dei rispettivi punti di partenza, nonché nella disposizione destrorsa o levogira rispetto all’assialità somatica. “Questenādī, continua M.Eliade, sboccano rispettivamente nella narice sinistra, nella narice destra, nel brahmarandhra (asse cerebro-spinale), nell’occhio sinistro e nell’occhio destro, nell’orecchio destro e nell’orecchio sinistro, nella bocca, nell’organo genitale e nell’ano; ma esistono delle varianti: alcune nādī raggiungono, secondo altri testi, i talloni”[9].
L’unico dubbio può sorgere in riferimento alla corrispondenza con il sen Kalathari, che tuttavia non approfondiremo in questa sede essendo nota la sua atipicità. Tralasciando anche i raffronti con i meridiani cinesi, peraltro già abbondantemente evidenziati nell’articolo di Cristina Radivo[10], prediligeremmo qui puntualizzare, piuttosto, le funzioni soteriologiche possedute dagli stessi (non in senso fideistico ovviamente) con particolare riguardo a quell’orientamento epistemologico, su cui si fonda il pensiero orientale citato all’inizio. Tale pensiero costituisce la realtà a priori dell’arte medica, sia indiana che cinese, ma non solo, e determina altresì la “condizione spirituale” del terapeuta.
P.Filippani Ronconi, sempre nel medesimo articolo, ci rammenta che, in oriente, l’esistenza stessa è di per sé una “malattia”orogya, in thai โรค-rohk, sia fisica che metafisica, attuandosi in essa quell’illusione esistenziale che gli indù chiamano maya, da cui scaturisce l’afflato per la conquista dell’immortalità e della libertà, mukti o moksa o utilizzando una categoria buddhista nirvana, dalla catena infinita delle esistenze detta samsāra. Per cui, scrive: “La guarigione è di per sé l’inizio di un movimento che conduce all’immortalità” la quale è postulata come scopo pratico dello Ayurveda[11]”. Anche il massaggio, perciò, in tale contesto - aggiungeremmo noi – riveste un ruolo, per quanto marginale, di disciplina soteriologica rivolta alla reintegrazione del Sé umano alla sua realtà cosmica, che è la condizione primordiale dell’essere.
I testi ripetono che, nel non-iniziato, le nādī sono divenute “impure”, che sono “ostruite” e che perciò è necessario “purificarle” con gli āsana, con il prānayāma e lemudrā[12], ovvero altresì con il Massaggio Thailandese, che ne rappresenta un valido succedaneo, il cui fine è – ricordiamo- quello di condurre la suaccennata polarità energetica, Idā e Pingalā, sempre in quest’ottica tantrica che transunstanzia il corpo, a realizzare un maithuna o un’unio mystica interiore nell’interciglio, tra epifisi ed ipofisi, sede delle funzioni psichiche e noetiche, onde cristallizzare un embrione di arogya, la condizione di non-malattia pre-esistenziale, e conseguentemente, di extrasamsarica consapevolezza.
 Ribadendo la verificabilità delle radici storiche indiane del Massaggio Thailandese, legate alla mitica figura di Moo Shivago Komarpaj o Jīvaka-Komārabhacca, esaurientemente sviscerate da Cristina Radivo[13], relativamente ad eventuali influenze reciproche tra Cina e India abbozzate all’inizio, ci preme qui allegare un ulteriore dato, riportato sempre da P.Filippani Ronconi, il quale citando lo studioso J.Fillozat, nella cui memoria, pubblicata nel Journal Asiatique del 1970, cerca di ricostruire la storia dei prestiti del taoismo allo Yoga, a partire dal 646 d.C, allorché “Kumāra Bhaskaravarman, re dell’Assam, ricevette dall’Imperatore della Cina la traduzione del 道德經 - Dàodé jīng di 老子- Lăozĭ. Affermando l’autore, che sebbene i principi sui quali è fondato lo Yoga appartengano alla civiltà indiana, pur tuttavia nell’evoluzione del sistema e nelle tecniche si riconosce un innegabile influsso cinese (…)”, tanto da giustificare in seguito una via spirituale denominata cīna-cara o via-cinese. Ribadendo la verificabilità delle radici storiche indiane del Massaggio Thailandese, legate alla mitica figura di Moo Shivago Komarpaj o Jīvaka-Komārabhacca, esaurientemente sviscerate da Cristina Radivo[13], relativamente ad eventuali influenze reciproche tra Cina e India abbozzate all’inizio, ci preme qui allegare un ulteriore dato, riportato sempre da P.Filippani Ronconi, il quale citando lo studioso J.Fillozat, nella cui memoria, pubblicata nel Journal Asiatique del 1970, cerca di ricostruire la storia dei prestiti del taoismo allo Yoga, a partire dal 646 d.C, allorché “Kumāra Bhaskaravarman, re dell’Assam, ricevette dall’Imperatore della Cina la traduzione del 道德經 - Dàodé jīng di 老子- Lăozĭ. Affermando l’autore, che sebbene i principi sui quali è fondato lo Yoga appartengano alla civiltà indiana, pur tuttavia nell’evoluzione del sistema e nelle tecniche si riconosce un innegabile influsso cinese (…)”, tanto da giustificare in seguito una via spirituale denominata cīna-cara o via-cinese.
Simultaneamente ci fu una missione dei singhalesi: Vajrabodhi, Amoghavajra e Subhākarasimha che portarono all’introduzione in Cina delle specie più raffinate di Tantra[14]. Ampliando ulteriormente il campo d’indagine, unitamente ad un raffronto con il nostro proposito euristico di individuare un archetipo paleoasiatico di massaggio che sottenda tutti gli esistenti stili orientali, menzioneremo ancora una volta il pregiatissimo articolo del prof.P.Filippani Ronconi, il quale in questo scambio vicendevole di due correnti spirituali – l’indiana e la cinese – ravvisa il riverbero di un remoto retaggio sibiro-sciamanico[15]a noi particolarmente caro.
|
[1] Le quali indipendentemente dal nome: ki (giapponese), qi (cinese), prana (indiano), phlang cheet (thai), khii, khiimor’ (mongolo), identificano sempre il medesimo concetto.
[2] Adottando gli ideogrammi cinesi, i giapponesi hanno importato anche la loro pronuncia — detta on —, modificata secondo la propria fonetica.
[3] Vd. art. di Cristina Radivo in http://www.waithai.it/pizzico.php
[4] P.F.Ronconi, art. Orientamenti della Medicina Indiana, pg. 127. M.Eliade, Lo Yoga, Milano 1995, pg. 225 ed ancora A. Avalon, Il Potere del Serpente, Roma 1982, pg. 91-96.
[5] M.Eliade, Lo Sciamanismo, Roma , 1983, pg. 290. Il dato potrebbe avere un’importanza per le eventuali influenze che questi complessi potrebbero aver esercitato anche sul tema del nostro articolo, per le circostanze in cui il suo fondatore, il dott. Shivago si formò, vd. nota 10.
[6] Jacques Lavier, L’agopuntura cinese 1973 Ed. Mediterranee
[7] J.Schatz, C.Larre, E.Rochat de la Vallée, Agopuntura, Giunti, 1987
[8] P.F.Ronconi, art. Guarigione e Immortalità.
[9] M.Eliade, Lo Yoga, Milano, 1995, pg. 225-226.
[11] P.F.Ronconi, op.cit.
[12] M.Eliade,op.cit.
[13] Vd. http://www.waithai.it/pizzico.php, di estremo interesse è la formazione di Jīvaka nella città di Taxila, oggi Pakistan.
[14] P.F.Ronconi, op.cit.
[15] P.F.Ronconi, op.cit.
0 commenti:
Posta un commento